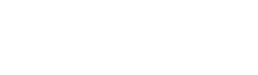di Felice Fasolino
Negli ultimi anni, tra gli strumenti che regolano la collaborazione sussidiaria tra Enti pubblici ed enti del terzo settore, sta avendo una sempre maggiore diffusione la co-progettazione, ossia “una modalità di affidamento e gestione della realizzazione di iniziative e interventi sociali attraverso la costituzione di una partnership tra Pubblica amministrazione e soggetti del privato sociale”.
Con la riforma che fu introdotta dalla L. 328/2000 si cercò di coinvolgere maggiormente gli enti del terzo settore nella costruzione di interventi sociali mirati al soddisfacimento dei bisogni della comunità per il tramite di innovativi strumenti di collaborazione. Lo strumento della co-progettazione fu finalizzato a superare il tradizionale rapporto sinallagmatico tipico del contratto pubblico che ha da sempre caratterizzato la relazione tra pubblico ed enti del terzo settore, e promuovere una nuova metodologia negoziale caratterizzata da una costruzione condivisa delle politiche sociali. In tal modo i soggetti non si limitano più a realizzare, con le risorse pubbliche, i progetti ideati esclusivamente dalla pubblica amministrazione, ma hanno la possibilità di partecipare attivamente insieme alle istituzioni pubbliche alla progettazione, organizzazione e realizzazione degli interventi sociali.
Le prime esperienze di co-progettazione furono avviate con il DPCM del 30 marzo 2001. Con questo intervento legislativo fu prevista, infatti, la possibilità, “al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, che i comuni potessero indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione per realizzare interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore avessero espresso disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi”.
All’epoca, l’ANAC con la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida dell’ANAC per l’affidamento di servizi e enti del terzo settore e alle cooperative sociali” previde che l’ente pubblico interessato ad instaurare un progetto di co-progettazione dovesse innanzitutto indire un’istruttoria pubblica attraverso la pubblicazione di un avviso di interesse in cui sono indicati un progetto di massima – predetermina gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definisce le aree di intervento, stabilisce la durata del progetto e ne individua le caratteristiche essenziali – nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l’individuazione delle proposte progettuali del terzo settore. Gli enti interessati a partecipare all’esperienza di co-progettazione erano chiamati a manifestare la loro disponibilità presentando una proposta progettuale, successivamente valutata dall’amministrazione. L’individuazione del soggetto o dei soggetti con cui collaborare si stabilì avvenisse mediante una selezione volta a valutare: i) il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali; ii) le caratteristiche della proposta progettuale; iii) i costi del progetto.
Dopo aver individuato i partner del terzo settore, si entra nel vivo della co-progettazione. Si procede ad approfondire e se necessario attuare una revisione del progetto di massima: l’amministrazione e il partner del terzo settore definiscono consensualmente ogni aspetto del progetto sino a renderlo definitivo per la successiva fase di stipulazione dell’accordo di collaborazione. Il progetto definitivo potrà attuarsi mediante gli accordi procedimentali di cui all’art. 11 della L. 241/1990, che costituiscono lo strumento più idoneo alla regolazione di rapporti che qualificano giuridicamente la relazione di sussidiarietà orizzontale tra ente pubblico e terzo settore. Sono individuabili tre principali tipologie di accordi procedimentali atti a regolare i rapporti nella sussidiarietà: accordi di gratuità, accordi di sostegno e accordi di collaborazione. La forma più strutturata e avanzata di rapporto nella sussidiarietà si realizza con gli accordi di collaborazione ex art. 119 D.lgs. 267/2000.
Con la stipulazione dei suddetti accordi, il soggetto del terzo settore diventa ufficialmente un collaboratore della pubblica amministrazione con cui condivide responsabilità e risorse – diversamente dall’appalto il collaboratore ha l’obbligo di mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche – della produzione dei servizi co-progettati. L’ente pubblico, infatti, non eroga un corrispettivo a favore dell’ente del terzo settore per la realizzazione delle prestazioni né un contributo a sostegno degli oneri da quest’ultimo sostenuti. Per regolare l’aspetto economico della co-progettazione pubblica amministrazione ed ente del terzo settore dovranno dunque prevedere un piano economico in cui distinguere gli oneri a carico dell’ente pubblico e quelli a carico del partner del terzo settore e stabilire delle forme di rimborso dei costi sostenuti per la collaborazione.
La co-progettazione è stata definita anche dal Codice del terzo settore (D.lgs 117/2017) che all’art. 55 viene descritta come “procedimento finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento”. Con l’introduzione del suddetto Codice viene ampliato l’ambito applicativo della co-progettazione, che non si limita più agli ambiti definiti dalla L. 328/2000 ossia i servizi sociali, i progetti sperimentali e innovativi, ma si estende a tutti i servizi di interesse generale definiti dal Codice. Il Codice del terzo settore costituisce una normativa di grande importanza poiché si tratta della prima produzione legislativa ordinaria (dopo più di quindici anni!) che ha permesso, in particolare attraverso l’art. 55, di introdurre nell’ordinamento il principio costituzionale di sussidiarietà così come definito dall’art. 118 della Costituzione modificato con la riforma del 2001.
Dopo i rilievi dell’ANAC sui profili di possibili disarmonia relativamente alla disciplina dell’affidamento di servizi sociali proprio tra il Codice del terzo settore e il Codice dei contratti e la pronuncia del Consiglio di Stato rispetto a se fosse corretto ritenere che l’applicazione del Codice dei contratti pubblici dovesse essere esclusa da ampi settori di attività affidati agli organismi del terzo settore, il nuovo codice degli appalti non fuga tutti i dubbi in materia e questo resta un ambito di approfondimento necessario se si vuole valorizzare il valore delle metodologie di co-progettazione, pur rendendo evidente che gli appalti appaiono la scelta prevalente da seguire per l’instaurazione di progetti tra enti pubblici ed enti del terzo settore.
Naturalmente questo percorso influenza i rapporti di collaborazione. Resta affermato il carattere discrezionale di valutare l’opportunità di utilizzare come modalità di affidamento di servizi e di costruzione di progetti anche la metodologia e gli strumenti della co-progettazione. Ormai vi è giurisprudenza anche di livello costituzionale che chiarisce come la scelta tra appalto e co-progettazione deve essere giustificata da ragioni oggettive, legate alla natura del servizio e alle finalità sociali che si intendono perseguire. Indubbiamente, non è legittimo utilizzare la co-progettazione solo per evitare le procedure competitive previste per gli appalti pubblici. Spetta, quindi, agli Enti locali non lasciarsi intimorire ed operare una forte scelta strategica verso la co-progettazione, evitando di rifugiarsi nel terreno più conosciuto degli appalti pubblici.
Questo modello si dimostra particolarmente efficace nel contesto di progetti dove la flessibilità e la cooperazione tra pubblico e privato sociale sono fondamentali per il successo degli interventi, anche nell’attuale fase di attuazione di ingenti programmi di interventi sostenuti con fondi comunitari. Gli Enti possono preferire la co-progettazione diretta quando i bisogni del territorio e le modalità di intervento sono definiti e la metodologia della co-progettazione appare più flessibile e adattabile alle esigenze dei servizi sociali, rafforzando la capacità delle amministrazioni di rispondere tempestivamente alle necessità della comunità. Tale possibilità di scelta evidenzia come tra il regime degli appalti classico e la co-progettazione siano in continua interazione, dando forma a un nuovo equilibrio e consolidando così un sistema di amministrazione condivisa.
Art. 55 D.lgs 117/2017
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
- In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
- La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
- La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
- Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.