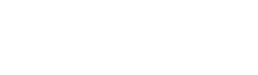di Lucia Serino
Intervista a Carmine Pacente, esperto di fondi europei, membro del Comitato delle regioni a Bruxelles e consigliere comunale di Milano
Si può avere il cuore sulle vicende della squadra di calcio del proprio paese d’origine, a Sud, a circa 800 chilometri da dove si vive e si amministra, Milano. E la testa nel cuore dei processi europei. Ma a ben riflettere le due cose non sono disgiunte perché i conti “freddi”, neutrali, delle cancellerie europee acquistano valore solo se si localizzano, se tengono cioè conto delle differenze territoriali e dunque dei bisogni specifici delle comunità di persone alle quali sono destinate.

Carmine Pacente, consigliere comunale di Milano, partito studente da Vallo della Lucania, ti offre il vantaggio di una doppia prospettiva, da Nord a Sud andata e ritorno, con la capacità di sintetizzare in un approccio multilivello la discussione sulle potenzialità della politica di coesione, l’impatto sullo sviluppo dei territori, i rischi all’orizzonte. All’indomani di una trasferta per seguire da vicino l’amata Gelbison (è la squadra di Vallo della Lucania) lo intercettiamo sulla strada di ritorno nel capoluogo lombardo. Sono giorni di rapido cambiamento degli scenari internazionali. Il riposizionamento dei propri valori nei periodi di crisi accresce la responsabilità a lavorare sugli strumenti giusti per non vederli opacizzare.
Pacente, 46 anni, laurea alla Bocconi in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Internazionali, specializzato nella programmazione e gestione dei fondi europei (ne ha scritto in varie pubblicazioni), è dal 2020 Membro del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles e, in particolare, della Commissione “Politica di coesione territoriale, fondi strutturali e bilancio europeo” e, nel consiglio comunale di Milano (eletto due volte) è Presidente della Commissione consiliare “Fondi europei e PNRR”.
Consigliere, partiamo dall’Agenda urbana. Lei è l’autore del progetto di parere discusso in commissione Coter sulle città metropolitane, gli investimenti in sostenibilità e la politica di coesione. Iniziamo da qui, la politica di coesione per i grandi agglomerati urbani può avere un impatto a cascata sulle aree più periferiche, fino a che punto?
“Sì, abbiamo discusso il tredici marzo in commissione Coter il parere del quale sono relatore che è stato poi approvato e quindi sarà discusso in plenaria il prossimo mese di maggio. Il timing sembra essere proprio quello giusto perché una delle priorità che il commissario Fitto, che ha la delega ovviamente in questo mandato, è quella di costruire e di rafforzare l’agenda urbana europea. Dovrebbe fare una prima proposta entro la fine dell’anno quindi entro il 2025 se consideriamo che il parere del quale stiamo discutendo mi è stato assegnato formalmente a inizio ottobre del 2024, poi abbiamo fatto la discussione del working document a dicembre nella prima riunione Coter, poi il secondo passaggio a marzo e se dovessimo approvarlo come spero e come sembra a maggio è chiaro che il timing è giusto perché il comitato delle regioni con questo parere di iniziativa darebbe alla commissione europea la sua opinione rispetto alla nuova agenda urbana europea”.
Che tipo di interesse ha riscontrato? Perché i tempi sono importanti?
“Questo parere l’abbiamo costruito avendo il contributo di tantissime città europee. Abbiamo audito Eurocities, sono stato ospite delle metropolitan authorities durante il loro convegno di Amsterdam, abbiamo fatto diverse audizioni, abbiamo ricevuto tanti documenti da tantissime grandi città europee, una cinquantina di città europee ci hanno inviato le loro riflessioni, e quindi c’è veramente molto interesse. Abbiamo fatto anche un’audizione organizzata dall’IFEL a Roma lo scorso 26 febbraio con un panel di esperti (al quale ha partecipato anche IFEL Campania con il suo direttore generale Annapaola Voto, in basso), anche lì sono stati ricevuti diversi feedback che poi abbiamo introdotto nel parere. Quindi i tempi sono importanti per provare a costruire o a dare un contributo a questa nuova grande importante agenda urbana europea che riguarda i grandi agglomerati urbani quindi le grandi città e le aree metropolitane ma riguarda però anche le città medie e le cosiddette aree funzionali. C’è un pericolo, dal mio punto di vista, quello della centralizzazione di decisioni e strumenti”.
Perché è un rischio? Non sempre la de-centralizzazione della politica di coesione garantisce i risultati, a volte li disperde.
“Non è proprio così. Noi vogliamo fare una cosa diversa, cioè vogliamo rafforzare l’approccio territoriale alla politica di coesione in particolare valorizzando il ruolo delle città, delle grandi città e dei grandi agglomerati urbani e anche delle città medie. Facciamo l’esempio di Milano, la città nella cui amministrazione sono ormai al secondo mandato, ma potremmo fare lo stesso esempio per Napoli e tutte le grandi città italiane, per restare a casa nostra. La differenza tra il comune capoluogo e tutto ciò che c’è intorno è enorme in termini di servizi, di trasporti, di residenze abitative. I documenti che ci hanno inviato lo certificano quindi ormai è abbastanza dimostrabile e verificabile che, purtroppo, molte volte gli strumenti che la politica di coesione ha messo a disposizione delle città si limitano al perimetro del comune capoluogo e non riescono invece ad andare oltre e a considerare i grandi agglomerati urbani come dovrebbe essere e cioè travalicando i singoli confini amministrativi, pur non essendoci soluzione di continuità nelle aree metropolitane. Non possiamo fare, è solo un esempio, che un programma nazionale come MetroPlus sia nella disponibilità, diciamo così, decisionale esclusivamente del comune capoluogo sebbene sia previsto che poi alcune risorse debbano essere destinate anche all’area metropolitana. Di fatto ciò accade abbastanza raramente”.
E cosa proponente?
“Innanzitutto vorremmo che la riserva minima obbligatoria del fondo europeo di sviluppo regionale destinato allo sviluppo urbano sostenibile aumenti nella prossima programmazione. Può sembrare una cosa banale perché lo si chiede sempre. Vorremmo che fosse introdotta una riserva minima obbligatoria per le strategie di sviluppo urbano anche nel fondo sociale europeo plus, attualmente non c’è, pensiamo ad alcune questioni cruciali come la gestione del fenomeno demografico. In sostanza, noi proponiamo un dialogo diretto o più diretto tra commissione europea e città. Le azioni innovative urbane, quelle strutturali, possono chiamarsi come si vuole, diciamo le risorse destinate alla competitività, hanno bisogno anche nella fase di programmazione degli interventi del coinvolgimento delle città per capire le reali necessità dei territori. E mi riferisco sia agli strumenti del piano nazionale di ripresa e resilienza, sia agli altri strumenti europei”.
Più in generale, considerate anche le questioni internazionali, perché le politiche di coesione sono importanti?
“La coesione è il nostro valore fondamentale, è una linea Maginot. Per noi la coesione non si tocca, il mercato unico non esiste senza coesione e quindi è assolutamente illusorio, non dico smantellare, ma ridimensionare, non solo questa politica ma anche questo concetto. La coesione serve a ridurre i divari territoriali essenzialmente, quindi a far sì che i territori che corrono di meno possano progressivamente avvicinarsi, tendere ad avvicinarsi a quelli che corrono un po’ di più e, contemporaneamente, a favorire i territori che sono più avanti attraverso i meccanismi di competitività. Se non c’è questa tendenza all’armonizzazione, anche il mercato unico viene meno e quindi i pilastri dell’Unione Europea saltano, noi ci spingiamo a dire che dopo la pace, la coesione è il valore fondamentale dell’Unione Europea”.
C’è il rischio che i fondi di coesione possano essere utilizzati per altre urgenze europee?
“Noi l’abbiamo già visto in questi anni. Ogni volta che c’è stata un’emergenza, il Covid, il caro Energia, la gestione dei rifugiati, sono state prese risorse dalla politica di coesione dell’Unione Europea”.
Ma per quale motivo?
“Perché è considerata una spesa di salvadanaio. Agricoltura e coesione assieme fanno i due terzi del quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea, e quindi ogni volta che c’è stata l’emergenza e la necessità di fondi, siamo andati ad attingere lì. Durante il Covid c’era una necessità di prendere risorse immediate per far fronte ai problemi sanitari e cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto: andiamo a prendere risorse della coesione, eventualmente non ancora investite e possiamo, se vogliamo, riprogrammarle velocemente. Ricordiamo le deroghe a tutti i vincoli che normalmente sono previsti per utilizzarle per gli scopi che il Covid ha reso necessari. L’abbiamo fatto anche noi a Milano nel nostro piccolo. Questo è per dire che se ogni volta che c’è un’emergenza si prendono i fondi per la coesione è chiaro che questo meccanismo però compromette la caratteristica fondamentale dei fondi. Li chiamano di coesione, ma sono rimasti fondi strutturali che devono finanziare delle politiche strutturali e non singole emergenze. Una volta il Covid, una volta l’energia, un’altra volta la difesa, per carità, tutte priorità assolute, però noi non possiamo snaturarli eccessivamente perché sono fondamentali per tenere assieme e per armonizzare questa Unione Europea. Il rischio è che può saltare tutto, a partire dal mercato unico, come dicevo prima, come scrive Enrico Letta nel suo rapporto. La posizione del CDR su questo è chiarissima, cioè noi difendiamo non solo la politica di coesione, ma l’approccio territoriale, quindi vogliamo che regioni e città non solo siano protagoniste, ma lo siano sempre di più. Il mio parere poi in particolare va sulle città, devono avere molto più spazio, nel senso che ho prima raccontato”.
Il protagonismo delle città, delle regioni pone un problema che a livello territoriale esiste dal punto di vista amministrativo A livello locale un ostacolo significativo alla spesa dei fondi, alla progettazione, è la scarsa capacità amministrativa. In questo si inserisce il ruolo degli istituti come IFEL Campania.
“Sì, è un tema assolutamente centrale, mi vede particolarmente sensibile e anche severo. Siamo oggi in una situazione in cui la coesione tra Est e Ovest dell’Unione Europea tutto sommato sta funzionando, perché una tendenza alla convergenza c’è, perché come dico spesso, alla richiesta di solidarietà bisogna che si accompagni obbligatoriamente e necessariamente anche un’assunzione di responsabilità forte, il tema della valutazione dell’impatto è decisivo chiaramente, è centrale. Se noi guardiamo l’indice sulla competitività regionale che la Commissione europea pubblica periodicamente, io faccio anche delle audizioni su questo ogni volta che pubblicano quello nuovo, ci rendiamo conto che, e stiamo al quadro del nostro Paese, le regioni italiane continuano a perdere competitività, praticamente tutte, quasi su tutti gli indicatori, da nord a sud. Quindi vuol dire che anche queste risorse, che hanno ovviamente un impatto parziale, ma comunque anche queste risorse e questi strumenti alla fine non danno l’impatto sperato, nonostante il passare degli anni e questo non possiamo più consentircelo. Il risultato non è spendere le risorse, ma il risultato è che cosa otteniamo dalla spesa di queste risorse, perché i fondi sono strumenti, non sono obiettivi, e quindi dobbiamo chiederci se il pil pro-capite aumenta o no in un territorio, l’occupazione aumenta o no e le infrastrutture aumentano o no? Allora se andiamo a misurare tutte queste cose avremo molte sorprese negative. Però se il problema esiste, è centrale e va affrontato una volta per tutte, la soluzione a mio giudizio non è centralizzare il processo. C’è un altro tema che voglio segnalare…“.
Prego
“La coesione funziona paradossalmente molto di più in contesti che ne hanno meno bisogno, mentre funziona molto di meno nei contesti che necessiterebbero di questi strumenti e di queste risorse per potenziare la loro competitività. C’è l’ostacolo territoriale, quindi rischiamo che non soltanto non centriamo l’obiettivo che è l’armonizzazione, ma addirittura che facciamo il contrario, cioè che i gap aumentino. L’operazione riesce ma il paziente muore, questa cosa è inaccettabile. Ribadisco che sulla base di queste evidenze non possiamo concludere che siamo favorevoli alla centralizzazione e quindi andiamo a penalizzare un approccio che invece in alcuni territori funziona e che avrebbero bisogno molto di più, non solo di strumenti e risorse, ma anche di protagonismo decisionale, come dicevo in partenza, per condividere quali sono le politiche e le priorità che vanno finanziate. Noi a Milano, facciamo l’esempio, senza le risorse che abbiamo in questo periodo di programmazione tra piano nazionale di ripresa e resilienza, fondi di coesione, programmi europei a gestione diretta non riusciremo a fare nessun investimento. E qui viene fuori un altro problema, le risorse europee spesso diventano sostitutive e non addizionali rispetto a quelle nazionali, chiaramente perdendo una buona parte del potenziale che dovrebbero avere, il meccanismo non funziona più o comincia già all’inizio a non funzionare. Ma detto questo, noi abbiamo risorse per poter fare cose fondamentali, senza le quali non potremmo farle e allora non possiamo, perché alcuni territori non funzionano, dire “centralizziamo”. Ci sono i problemi che evidenziavo prima, sono molto seri, ma non vanno affrontati centralizzando”.